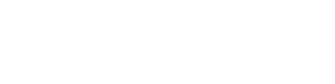Quando la televisione era in cucina e non viceversa, i cuochi erano gelosi delle loro ricette. C’erano piatti che per decenni garantivano il fatturato di un ristorante in quanto la gente si spostava, o meglio ritornava, in un locale per assaporare una precisa specialità.
Oggi pare una stranezza perché ci siamo abituati a vedere cuochi che confezionano di tutto: dagli hamburger alle terrine di foie gras, dai panettoni al ramen ma qualche tempo fa il titolare era spesso il maître o direttore di sala e sua moglie, oppure un cuoco-dipendente, stavano in cucina. Io
sono cresciuto in questi ambienti, con queste gerarchie.
Diciamo quindi che un ristorante di successo poteva avere due, tre piatti di riferimento e tutto il resto del menù faceva da corollario. Era logico quindi aspettarsi una certa riservatezza nel custodire le ricette più importanti a differenza di quanto avviene oggi, dove tra comparsate televisive e corsi di cucina, gli chef svendono i loro cavalli di battaglia per un minuto di eurovisione.
Il “coniglio alla Lumira” e’ uno dei piatti più ordinati, più rappresentativi e longevi del mio ristorante ed ha una genesi articolata anche se devo confessare che il suo percorso evolutivo non parte da qui. E’ talmente diverso da qualsiasi altro coniglio della zona da essere attribuito alla creatività dello chef ma non è così, o almeno non solo.
In un ristorante distante 150 chilometri da Castelfranco, circa 40 anni fa, questa preparazione di stampo tradizionale (in quella zona) caratterizzava il menù. Mio padre, grande compagnone nel pieno della sua forza espressiva, divenne grande amico del padre di colui che oggi gestisce il ristorante in questione e che sempre oggi e’ a sua volta divenuto un mio grande amico. Beh il loro rapporto assunse tale grado di fraternità da indurre il compianto collega a costringere la moglie a rivelare la segretissima ricetta del suo coniglio a mia nonna. Penso sia stata l’unica volta che ciò accadde.
Casualità: le due donne protagoniste dell’episodio si chiamano Nella, entrambe e sono nate nel 1923.
Quando incontrai “l’altra Nella” e le raccontai la storia, si commosse profondamente, incredula di sapere che tantissimi clienti affollassero i locali di un remoto ristorante emiliano per mangiare il
“suo” coniglio.
Ma cos’è e soprattutto com’è questo piatto così ricercato e’ presto detto: un coniglio in umido ma in bianco (in Emilia usa la “cacciatora” che però è rossa di pomodoro). Ha una spiccata acidità dovuta
alla cottura in una soluzione di vino bianco, aceto e acqua, con l’aggiunta di erbe aromatiche autoctone, aglio e acciughe. La carne viene ricoperta di liquido, incoperchiata e cotta a fuoco vivo fino a che si asciuga. Senza reazione di Maillard. A quel punto e’ pronto per essere servito, con la sua salsa in riduzione.
E’ curioso notare come in tutti questi anni la ricetta abbia assunto sfumature così diverse nei due locali da essere difficilmente riconoscibile.
Pensai a una carota quando aiutando mio figlio nei compiti sfogliai l’abecedario e vi trovai l’immagine di un coniglietto intento a rosicchiarne una di dimensioni epiche. Il congilio e la carota, un’associazione consolidata come il gatto e il gomitolo, il maiale e la ghianda. Corsi letteralmente in cucina e iniziai le prove, deciso ad ottenere una carota che si potesse rosicchiare stringendola in pugno, e magari dissotterrandola come avrebbe fatto un coniglio selvatico. Creai la terra unendo maltodestrine all’olio di nocciola tinto di carbone vegetale, aggiunsi una polvere di porro bruciato per la dolcezza e quella di olive per l’acidita, infine tostai alcune mandorle per dare croccantezza e colore oltre al profumo di fondo di caffè che caratterizza le torte tenerine della zona. Guardare questa terra oggi mi inorgoglisce: sembra la nostra, un mista di argilla, ghiaia e sabbia dei calanchi. Passai poi alla carota che, nella sua odierna versione è marinata nell’anice per osmosi, poi farcita di crema di topinambur e interrata nel vasetto di terra in modo da stimolare il ricordo di una sambuca con la mosca.
Rido quando sento parlare di “rivisitare la tradizione”, essa non si rivisita, si può solo accompagnare lentamente verso nuove forme. E’ come spostare i mobili di una casa: servono casa, mobili e serve abitarci per lungo tempo.